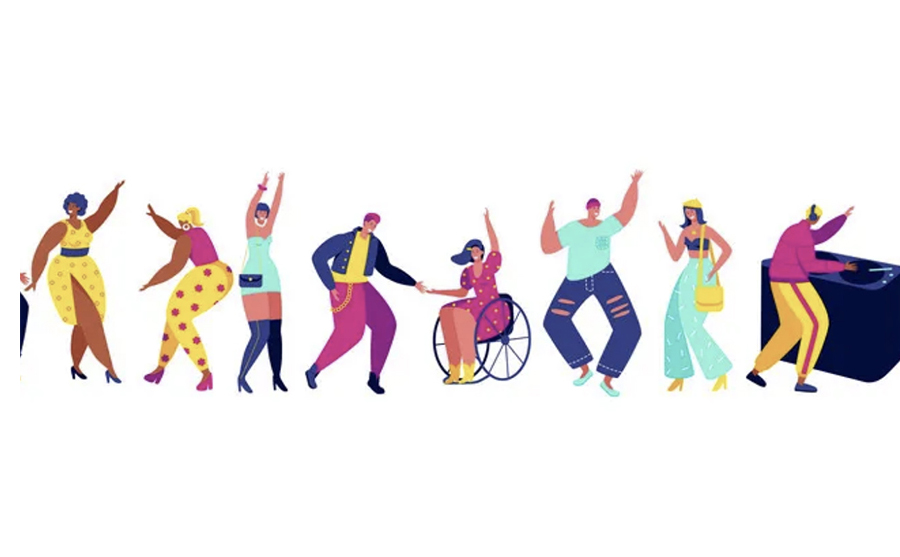Reduce da una bellissima edizione di Oriente Occidente, il celebre festival di danza contemporanea che quest’anno compie ben 43 anni, mi accingo a scrivere il numero di questa settimana ispirata, nutrita e arricchita da ciò che ho visto e ascoltato.
Questo appuntamento è per me sempre una ghiotta occasione per immergermi totalmente nel mio elemento come spettatrice, insegnante e quest’anno ho avuto anche il privilegio di essere presente come relatrice in una conferenza sul tema della sostenibilità dell’arte. A corollario, tanti incontri con persone (e personaggi) che ho occasione di vedere solo a Rovereto durante il festival, con cui intavolo sempre interessanti scambi sul presente e sul futuro della danza. Si tratta di una vera e propria vacanza-laboratorio, posta proprio a ridosso dell’inizio della stagione d’insegnamento come un pieno di benzina. Ogni anno è una vera e propria festa.
Oriente Occidente è anche un festival dalla profonda sensibilità verso le tematiche sociali, ambientali e di inclusione delle minoranze, nonché una particolare attenzione al pubblico più giovane, con incontri e offerte a loro dedicate, una vera e propria mosca bianca nel panorama nazionale. Il festival si snoda in giornate intense in cui è possibile assistere anche a due spettacoli al giorno più le conferenze, un ricco contesto capace di proiettarsi in avanti, verso la nuova danza, con sguardo lungimirante e brillanti intuizioni.
Il concetto di “nuova danza” viene spesso percepito dagli addetti ai lavori come qualcosa che ha a che fare solo ed esclusivamente con il corpo, con la ricerca del movimento dal punto di vista estetico/bio-meccanico. Nel mio sentire invece, specialmente dopo questa settimana roveretana, credo di poter dire che è giunto il momento di allargare gli orizzonti, aprire la mente e il cuore ad un diverso modo di concepire, realizzare e fruire di quest’arte a partire proprio dallo stato di non-forma, dall’idea, fino ad arrivare alla sua realizzazione. Siamo ad un punto di svolta importante in cui è necessario mettere in discussione tutto, annusare l’aria come fanno gli animali prima della pioggia, per osservare dove la danza vuole andare e quale forma prendere, senza alcun attaccamento (ma con molto rispetto) nei confronti di ciò che è stata finora.
Ho assistito ad una meravigliosa prima internazionale del celebre coreografo Sharon Fridman, che ha portato in scena un duo, intitolato “Go Figure”, interpretato da due splendidi performer : Samuel Cohen, terapista di body-mind movement, affetto da una sindrome neurologica che influenza il controllo dei muscoli, insieme a Tomer Navot, danzatore, insegnante di release technique e contacteur. I due, sotto la guida di Fridman, mettono in scena la diversità nuda e cruda, i limiti e le reciproche possibilità, utilizzate come leva per sostenersi a vicenda, imparare l’uno dall’altro senza nessun tentativo di prevaricazione, in modo autentico, onesto, trasparente.
Secondo un’idea obsoleta della danza alla quale siamo tutti un po’ affezionati, specie qui in Italia, sembra che l’accesso alla professione di quest’arte sia esclusivo per i soli corpi appositamente disegnati, conformi ad un modello precostituito di bellezza, con caratteristiche di prestanza e flessibilità sempre più estreme, preferibilmente bianchi. Ciò che sta avvenendo (che in realtà nel resto del mondo è già accaduto da tempo, basti pensare alla CanDoCo dance company fondata nel 1991, per guardare solo alla questione dell’inclusione a diverse forme di disabilità) è la manifestazione di una volontà collettiva di liberare l’idea stessa di corpo danzante da qualsiasi costrizione, apprezzare la diversità come opportunità di arricchimento, considerare il limite come occasione di crescita e di esplorazione creativa. L’opera di Fridman è potente, commovente, emozionante, vibrante, capace di trasmettere un messaggio profondo e di porre lo spettatore in uno stato di ipnotica estasi e presenza.
Non è mancata neanche la questione femminile, magistralmente rappresentata dall’opera di Kat Valastur, coreografa greca di stanza a Berlino, che ha messo in scena un vero e proprio atto rituale ispirato al mito di Ifigenia, nel suo “Strong Born” in cui tre splendide danzatrici hanno dato vita ad una danza sacrificale, svolta su una piattaforma simbolicamente circolare, utilizzando il ritmo e la ripetizione come strumento per portarsi (e portare il pubblico) in uno stato alterato della coscienza, una sorta di trance. La bellezza, la perfezione del movimento è qui generata dalla funzione, ossia l’azione di colpire, battere degli elementi di legno e di porcellana sparsi sui corpi per produrre suoni e ritmi in tutti i modi e le combinazioni possibili. Il pubblico ha potuto assistere a delicate e lentissime transizioni, seguite da momenti di grande esplosività e coinvolgimento emotivo alla fine dei quali il cuore di tutti noi batteva all’unisono con quello delle tre interpreti.
E queste sono solo due delle opere presenti nell’offerta di questo sempreverde festival.
Il corpo in movimento come custode di racconti, ambasciatore di messaggi, creatore di atmosfere, organismo spirituale che vibra di luce, capace di trasformare non solo lo spazio interno ma anche quello esterno. Questa per me è la nuova danza, un’arte inclusiva che lascia la parola ad ogni corpo, ogni cuore e ogni mente abbia qualcosa da dire e le competenze per farlo, a prescindere da tutto. Tornare a porre al centro dell’azione danzata l’urgenza che spinge un coreografo, un regista e i suoi interpreti a muoversi affinché – come accade in natura – sia la funzione a generare la forma perché il percorso inverso non porta a nulla di significativo.
“Non mi interessa come si muovono le persone ma quello che le muove” questo diceva l’immensa Pina Bausch e sì, sono consapevole di non dire niente di nuovo questa settimana, la frase di Pina contiene già in sé l’essenza stessa del movimento danzato al di là del linguaggio coreutico, delle forme, dei corpi. La “vera” danza, concetto con cui molti si sciacquano la bocca, non sta nella supremazia di un linguaggio rispetto ad un altro ma nella verità animica, nell’onestà dell’opera e dei suoi interpreti, nella pregnanza del messaggio in essa custodito, nel portare il pubblico a riflettere o partecipare attivamente, persino a diventare egli stesso la performance, mettendo con coraggio in discussione le proprie certezze, disturbando lo status quo, mostrando il mondo da un punto di vista diverso attraverso una chiave ironica, poetica, ascetica, anche violenta, use necessario, includendo -insomma – tutti i colori dell’animo umano.
La nuova danza è già qui, sta spingendo prepotentemente per emergere libera, irriverente, rivoluzionaria, basta lasciarle spazio per mostrarsi e quando finalmente esonderà in tutto il suo caleidoscopio splendore, nei suoi contrasti e nelle armonie date dalla moltitudine variopinta che contiene, tornerà finalmente ad essere il racconto prediletto, non verbale e universale, dell’intera umanità, uscendo dai salottini laccati su cui un’idea stantia e stitica della danza poggia le sue regali natiche.
Abbiamo bisogno di guardare all’umanità, ai cambiamenti che stiamo vivendo, al futuro che ci aspetta, esiste un’ardente brama (e allo stesso tempo un timore) di ritrovare noi stessi, di individuare quei principi etici che ci aiutino a vivere in armonia gli uni con gli altri, riscoprire la natura e il rispetto verso questa Grande Madre che ci ha dato i natali e un paradiso terrestre in cui vivere. Il concetto di Natura include macroscopicamente l’universo ma microscopicamente è il nostro corpo, il veicolo che abitiamo, quindi quale miglior strumento se non il linguaggio del corpo in movimento per potersi interrogare su chi siamo?